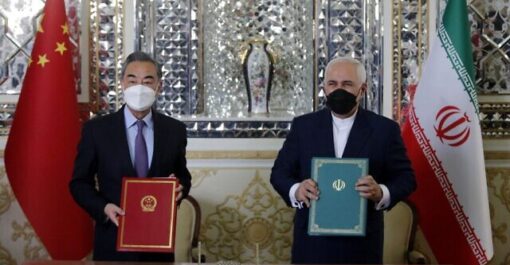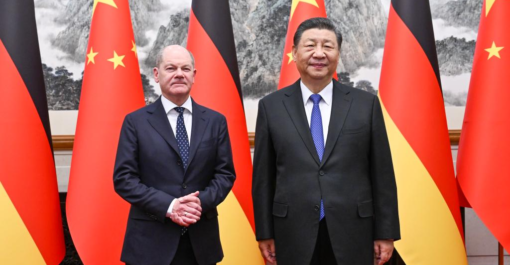All’ispettore di servizio quel pomeriggio non occorse molto per capire chi fossero le persone che si trovavano di fronte a lui.
I due punk non avevano nulla a che vedere col marocchino e fra i tre non c’era stata nessuna cessione di droga. Al ragazzo italiano venne trovato addosso solo uno spinello, a Jaffna nulla. Droga non ne aveva, ma la carta d’identità di Nevio Calegaro sì.
«Stammi a sentire Jaffna – gli disse l’ispettore – tu al gabbio ci finisci e ci resti tutta la vita: col cazzo che lo rivedi più il Marocco».
Mahmoud continuava a non capire nulla.
«Allora: rispondi! Perché lo hai ammazzato? Che ci facevi col vecchio? Una marchetta? E dai, che è andata così… il vecchio avrebbe voluto che tu gli facessi un “servizio” ma a te invece non andava. Cosa avrebbe voluto fare: infilartelo nel culo? Oppure… forse è vero quello che dici tu, cioè che non lo hai fatto fuori, ma allora perché ti abbiamo trovato in tasca la sua carta d’identità? Chi c’era insieme a te quella sera?»
Jaffna sbiancò in volto. Si era davvero cacciato in un gran casino. I poliziotti gli sviscerarono a brutto muso le loro ipotesi ricostruttive del delitto, dipingendo a tinte fosche tutti i possibili moventi alla sua base: una rapina a mano armata finita male, una lite degenerata per contrasti su una prestazione sessuale negata, un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Non esclusero nulla.
Anche se era troppo presto per delineare un quadro preciso, a ben vedere col delitto la droga in qualche modo poteva pure entrarci. Però bisognava andarci cauti per non commettere errori, dato che la stampa aveva puntato i suoi obiettivi sull’inchiesta del Meduna.
Il caso era di competenza della Procura della Repubblica di Pordenone. Di lì a poco era atteso il rientro in sede del pubblico ministero che se ne sarebbe dovuto occupare, la dottoressa Rosalba Catalano, che quel giorno si trovava in trasferta per servizio a Padova. Le prime indagini erano state condotte dall’Arma dei Carabinieri. Erano stati loro a trovare il cadavere al torrente, tuttavia, in seguito il destino aveva fatto sì che Jaffna finisse nelle mani della Polizia di Stato e adesso le due Forze dell’Ordine avrebbero dovuto necessariamente cooperare.
VIII
«Che fa dottore, lo interroga lei al marocchino?»
Chiese l’ispettore Battaglia al vicequestore aggiunto Zorzon mentre insieme salivano in ufficio dopo aver bevuto un caffè nel bar dietro alla questura.
Il funzionario non rispose alla domanda. In quel momento era sopra pensiero, con la mente lontana anni luce da quella cabina di alluminio dell’ascensore che lo stava riportando al piano dov’era la sua nuova stanza di dirigente della Squadra Mobile. Il suo sguardo apparentemente assente fissava la tastiera dai pulsanti arancioni.
«Come dici Battaglia? Ah sì, il marocchino dell’omicidio. Oggi ci mancava pure questa rottura, come se non bastasse tutto il resto».
Preceduta dal trillo dolce del campanello la porta automatica si aprì e i due uscirono. Dopo aver attraversato l’ampio pianerottolo si diressero nell’ufficio, una stanza arredata in maniera essenziale: una scrivania, tre poltrone, un paio di armadi schedario e un attaccapanni. L’ampia finestra a doppi vetri incorniciata da infissi in alluminio anodizzato consentiva una veduta su parte della periferia cittadina.
Zorzon si sedette al suo posto, Battaglia invece indugiò ancora un poco, distratto dalla variopinta copertina di una rivista di scienze sociali casualmente poggiata sulla scrivania.
«Chi ci va sulla Pontebbana? – Chiese il capo della Mobile un poco stranito – Guardate che io non voglio saperne niente eh… ve la dovete vedere tra voi. Decidete chi andrà davanti alla fabbrica e lasciatemi tutti gli altri che residuano. Dì, Battaglia: tu naturalmente resti con me. Oggi mi dovete garantire il massimo della forza perché è veramente una giornata di merda. Quindi non voglio sentir parlare né di distacchi sindacali e neppure che alla sovraintendente di turno gli è venuto il marchese: chiaro!?! Oggi tutti qua!»
In provincia di Pordenone i casi di omicidio erano davvero rari. Al massimo se ne verificava uno all’anno e quasi mai si registravano picchi maggiori, perciò il caso Calegaro aveva aggravato non poco il carico di lavoro della squadra. Per di più, quel giorno lì tutta una serie di eventi concomitanti avrebbero assorbito l’intero personale in servizio alla questura. Gli Antimilitaristi del Nordest avevano indetto un picchetto contro la NATO davanti alla base americana di Aviano ed era atteso l’arrivo di centinaia di manifestanti anche dalle regioni vicine; poi c’erano i metalmeccanici degli impianti di Porcìa, che minacciavano di bloccare il traffico sulla statale Pontebbana in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto di lavoro; infine ci si era messo pure l’omicidio del Meduna, col marocchino in stato di fermo e le indagini da avviare, per giunta, “in doppia” coi Carabinieri.
«Dottore – bisbigliò Battaglia – l’assassino ha sparato con una Glock 17».
Prima che Zorzon si esprimesse al riguardo trascorsero alcuni secondi. Conosceva molto bene le armi da fuoco e anche stavolta ebbe la certezza di fare bella figura sbrodandosi un po’ addosso la sua perizia.
«Glock 17 hai detto eh… – replicò prima di sviscerare tutta una serie di dati tecnici centellinandoli come in una litania – Glock 17, pistola austriaca in calibro nove per diciannove; ergo, secondo la vigente legislazione in materia di armi, considerata “da guerra”; media velocità alla volata, caricatore standard, eccetera, eccetera, eccetera… Mmmh, mi sa tanto che a sto’ vecchio lo ha fatto fuori qualche sborone di slavo arrivato da oltreconfine. Uno che ci ha voluto mettere anche la firma».
Quando poteva, il capo della Mobile andava al poligono a sparare con le sue pistole. Ci teneva molto alle sue armi, in passato, quando aveva prestato servizio a Trieste, si era aggiudicato il primo premio in numerose gare di tiro istintivo. Ma non si poteva definirlo un fanatico. Dopo il trasferimento a Pordenone, lo scarso spazio disponibile nel suo nuovo ufficio lo aveva costretto a stipare trofei e crest negli scatoloni di cartone, imballi che dai tempi del trasloco erano rimasti nello scantinato della sua abitazione, tra le bottiglie di tocai e i pneumatici da neve della macchina.
Ormai erano quasi due anni che guidava la Squadra Mobile di quella città, dove si era distinto per i suoi tratti marcatamente “operativi”. Il personaggio si prestava perfettamente al ruolo ricoperto: originario della provincia di Vicenza, figlio di un avvocato civilista e di una farmacista, era entrato in Polizia subito dopo essersi laureato in giurisprudenza; fisico slanciato e lunghi capelli biondi pettinati all’indietro, vestiva sempre in modo sportivo. Un uomo appassionato al suo lavoro, felice di svolgerlo non troppo lontano dall’altopiano di Asiago, dove aveva vissuto gli anni felici dell’infanzia e dove ancora risiedevano i suoi genitori, un luogo dove tornava ogni qual volta era possibile. Nel corso della sua brillante carriera di investigatore si era dovuto confrontare con realtà criminali di notevole levatura, come i clan albanesi del narcotraffico e la mafia del Brenta. Adesso era arrivato lì nella Destra Tagliamento, una piazza tutto sommato tranquilla.
***
A Pordenone una volante pattuglia continuamente la città. A quelli che sono costretti ad aspettare la corriera seduti per più di mezzora sulle panchine dell’autostazione può capitare di vederla passare anche un paio di volte. La potente Alfa Romeo coi colori d’Istituto procede lentamente sulla trafficata strada a senso unico che tange il largo piazzale. Gli agenti a bordo controllano che fuori tutto vada bene, attraversano il centro e poi si dirigono in periferia, infondendo in questo modo alla gente che li guarda transitare un briciolo di sicurezza in più.
Un’oasi di sicurezza con una completa gamma di offerte criminali, così è stato definito il Pordenonese, seppure al giorno d’oggi la malavita locale praticamente non esista più e quella che c’era in passato sia stata completamente falcidiata dagli arresti. In ogni caso droga in giro non ne manca e il riciclaggio di denaro sporco è una pratica non infrequente.
Fino ai primi anni Settanta lo schedario della questura aveva un volume estremamente ridotto. Nei pochi scaffali relegati all’interno di un piccolo stanzino erano depositate perlopiù pratiche amministrative, fascicoli digeriti nel tempo dal brontosauro della burocrazia. Nulla di veramente rilevante, con pochissimi casi di reati contro il patrimonio e la quasi inesistenza delle rapine. A incidere sulla tranquillità dei cittadini erano soltanto i furti. Per anni la delinquenza era rimasta relegata entro quella soglia minima definita da sociologi e criminologi come «fisiologica», anche perché, generalmente, i friulani per indole e carattere sono sempre stati ossequienti nei confronti dell’autorità.
Poi, però, con lo sviluppo economico della regione che portò al superamento delle sacche di povertà ancora esistenti, in quel tessuto socioeconomico sostanzialmente sano si andarono innestando dei corpi estranei che, gradualmente, mutarono la fisionomia criminale locale. La diffusione della droga rese la città un importante centro dello spaccio di eroina, che si andò a saldare con le altre grandi piazze di spaccio del Nordest. Ben presto, piazza XX Settembre non ebbe più nulla da invidiare al quartiere della Stanga di Padova o alla periferia milanese. A Pordenone il tasso di tossicodipendenti divenne paragonabile a quello dei grandi agglomerati urbani e, conseguentemente, si accentuò anche il fenomeno della microcriminalità.
In ogni caso, con un omicidio all’anno di media e in assenza di percepibili picchi di criminalità, il Pordenonese era rimasto un luogo relativamente tranquillo. Tranne rare eccezioni, non si ricordava praticamente nessun bandito di reale spessore, un dato che rendeva efficacemente la cifra della criminalità locale. Persino l’usura era un fenomeno contenuto, almeno fino all’approssimarsi della crisi finanziaria.
I numeri grossi venivano fatti dalla criminalità organizzata, però sotto traccia e con intelligenza. Da questo punto di vista Felicetto aveva fatto scuola: sulla penetrazione della sua organizzazione criminale in questa provincia non erano disponibili molte informazioni, però si sapeva che i collegamenti col tessuto economico locale c’erano stati.
Erano poi arrivati i clan gelesi, che avevano tentato di impiantarsi nella zona per condizionare l’assegnazione di alcuni appalti pubblici nel settore dell’edilizia, come quello di Aviano 2000, il megacomplesso residenziale in procinto di essere costruito presso la base aerea americana.
Infine c’erano le bande degli slavi, che calavano in Friuli per compiere azioni “mordi e fuggi”. Compagini estremamente violente che dopo aver compiuto i colpi riattraversavano immediatamente il confine.
Pordenone e il suo circondario erano dunque rimasti tranquilli, luoghi dove per la strada non si vedevano più neppure le puttane. Esse, infatti, non battevano più i marciapiedi, poiché si erano trasferite negli appartamenti, dove il maggiore livello di discrezione rendeva il loro sfruttamento certamente meno appariscente.
IX
«Allora Battaglia, andiamo a sentire sto’ marocchino cosa ha da dirci …come hai detto che si chiama?»
«Jaffna dottore, Jaffna Mohammad».
«Jaffna? Ma che è marocchino o cingalese?»
«Marocchino, marocchino… eh, già, è vero, il nome sembra proprio quello della città dello Sri Lanka …o sbaglio?!?»
Prima di porsi al cospetto del giovane extracomunitario fermato i due investigatori fecero il punto della situazione. A riassumere il tutto fu naturalmente Zorzon.
«Il morto in corpo aveva tre colpi di pistola semiautomatica Glock in calibro da guerra, un tipo di arma che non necessariamente può caratterizzare chi la usa, ma che comunque potrebbe fornirci lo stesso una traccia …diciamo puramente ipotetica. Però Jaffna non è jugoslavo e per di più è un balordo: quindi? E se l’arma del delitto, invece, fosse stata precedentemente nella disponibilità della vittima?»
Già, le pistole di Calegaro. Tuttavia, fra le armi da fuoco che il vecchio aveva regolarmente denunciato non figurava una Glock. Allora un’ipotesi plausibile poteva essere quella che l’avesse detenuta illegalmente. Al mercato nero con cento carte un “ferro” te lo porti via, mentre con duecentocinquanta ti ci compri pure una buona pistola. Jaffna potrebbe avergliela sottratta nel corso di una colluttazione o durante un tentativo di rapina.
Gli interrogativi permanevano numerosi: perché Calegaro si sarebbe dovuto accompagnare, per di più armato, con un tipo come Jaffna? Dove erano finite le sue armi: il revolver Franchi FR 83 calibro 38 special e la semiautomatica Beretta nove per ventuno, dato che non gli erano state trovate né addosso e neppure nella sua abitazione?
Zorzon abbozzò una prima conclusione.
«Questo qui, o era un fissato oppure temeva per la sua sicurezza: quale delle due secondo te ispettore Battaglia?»
Punto terzo: dov’era finita la sua macchina? La Crysler Gran Voyager di Nevio Calegaro fino a quel momento non era stata ancora ritrovata quindi le armi si sarebbero anche potute trovare al suo interno. Inoltre, con un po’ di fortuna, la macchina poteva divenire una fonte di altre tracce, per esempio quelle biologiche dell’assassino.
Infine il cellulare. Agli uomini della Mobile una sorpresa derivò dai risultati dell’esame sui tabulati della scheda SIM intestata alla vittima, quella rinvenuta nell’apparecchio trovato in tasca al marocchino. Da essi risultarono registrate delle telefonate sia in entrata che in uscita verso utenze di soggetti noti per essere dei piccoli spacciatori della zona.
Il quadro della personalità di quel vecchio si faceva sempre più fosco: chi era stato veramente in vita Nevio Calegaro?
Zorzon e Battaglia fecero ingresso nella stanza dove i loro colleghi avevano condotto il marocchino per l’interrogatorio. Il ragazzo era pallido in volto, provato dalla stanchezza e impaurito. Jaffna era un tipo dinoccolato, aveva i labbroni carnosi, mentre i suoi capelli, che portava rasati a zero, evidenziavano il profilo allungato del suo cranio. Vestiva come un rapper dei ghetti neri americani: blue jeans larghi e a vita bassa che lasciavano scoperti ventre e schiena, mentre ai piedi calzava un paio di scarpe sportive. Emanava un intenso olezzo, esagerato, come se si fosse cosparso del contenuto di un intero flacone di colonia. Un particolare che aveva dato la stura ai commenti ironici dei poliziotti presenti, in particolare dell’ispettore capo.
«Sentilo come profuma questo …allora, rispondi! Perché lo hai ammazzato al vecchio? Ci facevi le marchette vero!?! Che voleva farti il servizio? Dai, forza: chi avrebbe dovuto farlo il maschietto?» Jaffna si chiuse nel più totale mutismo.
L’ispettore capo si accorse della presenza nella stanza del dirigente e si voltò per salutarlo.
«Buon giorno dottore. Noi ci siamo permessi di scaldare i motori, ma ovviamente attendevamo lei per procedere».
L’ispettore si appartò quindi in disparte allo scopo di non farsi sentire dal fermato mentre si consultava a bassa voce col suo dirigente. Si poneva un problema procedurale non indifferente.
«Dottore, qua l’avvocato difensore ancora non si vede: che facciamo, andiamo avanti lo stesso o no? Il rischio è che questo ci crolli subito e che poi però non si possano utilizzare in dibattimento le sue dichiarazioni».
Zorzon appoggiò il pacchetto di sigarette e l’accendino sul tavolo, poi si sedette. Fissò negli occhi l’ispettore capo facendogli comprendere con lo sguardo che non si sarebbe dovuto ripetere l’errore commesso a Lesis.
In quel villaggio sperduto fra le montagne, una sera di estate dell’anno precedente all’uscita dall’osteria due ragazzi ubriachi uccisero il Toc fracassandogli a colpi di pietra la testa. La vittima era il bullo del villaggio, un balordo ormai in età matura che tuttavia non aveva perduto la voglia di fare il prepotente. La mattina seguente una pattuglia della Stradale trovò il suo cadavere riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. Anche in quel caso l’inchiesta venne condotta “in doppia”, i due indiziati furono portati nella stazione dei Carabinieri di Cimolais, dove dopo una notte di interrogatorio serrato uno di loro cedette confessando l’omicidio. Ma non lo fece di fronte al suo difensore, quindi quella dichiarazione non avrebbe potuto avere valore in dibattimento. Gli investigatori dovettero quindi ricominciare tutto daccapo, nella speranza di ottenere dagli accusati una nuova confessione.
«Macchine avanti piano – sussurrò Zorzon – intanto vediamo cosa ci dice. Magari è vero che lui non c’entra e che a Calegaro se lo sono “fatto” degli altri».
I poliziotti ripresero a fare domande. Il capo della Mobile rimase a osservare con apparente distacco quel ragazzo seduto davanti a lui, lasciando che gli uomini della squadra lo torchiassero per benino per farlo parlare.
«Dottore – esclamò l’ispettore – il ragazzo dice che le marchette lui non le fa e che è un buon musulmano».
Il capo della Mobile stette al gioco e interloquì col sottoposto.
«Ah sì… complimenti Mahmoud. Però i documenti e telefonini li “gratti” vero!?! Ma questo un bravo musulmano come te mica lo può fare sai».
Parlava col marocchino, ma i suoi pensieri erano altrove. Alle pistole. Sia a quella che aveva sparato sul Meduna che a quelle che la vittima aveva detenuto legittimamente, che però erano scomparse dalla circolazione.
Non solo, Zorzon stava anche riflettendo su quei piccoli spacciatori della zona e iniziava a convincersi che quel vecchio che avevano ammazzato non doveva essere poi così pulito e rispettabile come a prima vista appariva.
Nel corso del vertice fissato in Procura in tarda mattinata forse avrebbe potuto apprendere qualcosa di più sul caso. In fondo il morto lo avevano trovato i Carabinieri e sempre loro avevano sentito per primi un bel po’ di gente, compresi i fratelli della vittima. Intuì che da Jaffna non avrebbero cavato nulla, tentò comunque un affondo.
«Senti Mahmoud, lo sai bene che non hai alcuna possibilità. Tu lo hai disarmato, il perché sono cazzi tuoi e a noi non ci interessa, però …beh, però, dopo averlo disarmato gli hai sparato tre botti e ti sei portato via le sue pistole: fine. È inutile che rompi il cazzo col pianterello, perché con noi non attacca. Dai risultati dello stub uscirà fuori che le tue manine profumate hanno fatto tre buchi nel corpo al vecchio».
Ma Jaffna non cedeva. Non cadeva nella pur minima contraddizione e protestava continuamente la sua innocenza. Le cose erano due: o era uno molto abile a evitare i tranelli oppure era davvero sincero. Dopo una ventina di minuti di questa tiritera una sovraintendente in uniforme chiamò con discrezione il dirigente fuori dalla stanza per comunicargli qualcosa di importante.
«Dottore, una pattuglia ha trovato il mezzo che cercate. La Gran Voyager della vittima è parcheggiata chiusa a chiave in una stradina secondaria che costeggia la ferrovia in località Bivio FS Aurisina, fra Trieste e Monfalcone».
Finalmente una buona notizia. Così si sarebbe potuto recare in Procura con qualcosa in mano. A dire il vero, avrebbe preferito esaminare l’autovettura di persona, ma il previsto incontro con la piemme e il comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri non glielo consentì. Per il sopralluogo ad Aurisina delegò all’ispettore Battaglia, che sul posto si sarebbe interfacciato coi colleghi della scientifica.
X
Delitto del Meduna: le indagini forse a una svolta.
Arrestato marocchino trovato in possesso del cellulare e di un documento della vittima
Sul quotidiano più diffuso in provincia il titolo campeggiava a caratteri cubitali in prima pagina. Per una navigata cronista di nera come Mara Maritan non era stato difficile costruire una storia utilizzando gli scarsi elementi disponibili nelle prime ore dal ritrovamento del cadavere, però in seguito aveva perso lo slancio.
Aveva allora provato a mettersi sulle tracce dei parenti della vittima per fare un po’ di giornalismo del citofono, una specialità nella quale eccelleva, stavolta però senza apprezzabili successi, visto che i due vecchi Calegaro dopo la morte del loro fratello erano divenuti inavvicinabili.
In quel momento aveva disperato bisogno di qualche voce di prima mano per condire il suo pezzo successivo sul caso con il maggior numero possibile di particolari. Era sua intenzione fidelizzare i lettori per poi trascinarseli fino alla conclusione dell’indagine e, quindi, al processo.
La Maritan era molto scaltra, a volte pure troppo. Una che non si faceva scrupolo della sua tremenda invadenza. Se poteva schiacciava tutto e tutti come un Caterpillar. Per l’opinione pubblica locale, l’omicidio del Meduna costituiva indubbiamente una notizia importante, un’esecuzione a tal punto brutale non era certo un fatto frequente nel Pordenonese. Infatti, da quelle parti negli ultimi anni i casi di morte violenta erano stati o la conseguenza di rancori familiari oppure di liti occasionali degenerate a causa di improvvisi raptus di follia. In precedenza c’era stato un importante caso rimasto a lungo insoluto che aveva coinvolto la setta Telsen Sao, l’omicidio di Anna Laura Pedron, una giovane e affascinante baby sitter trovata cadavere all’interno di un appartamento del capoluogo. Non si era riusciti a risalire ai responsabili e il caso venne archiviato come opera di ignoti. Per il resto, tutte le altre indagini su degli omicidî erano approdate velocemente alla soluzione senza eccessive complicazioni.
La Maritan le aveva sempre seguite da vicino, cercando di restare costantemente incollata agli inquirenti e tampinando al contempo il pubblico ministero titolare dell’inchiesta. Stavolta però, almeno per il momento, a Palazzo di Giustizia e in caserma le bocche erano rimaste sigillate e per sapere qualcosa non le erano bastate neppure le sue entrature in questura.
La posizione dell’indagato era stata resa nota nei suoi aspetti di massima nel corso della conferenza stampa che aveva avuto luogo nella mattinata, dalla quale si era appreso che il marocchino fermato era stato sottoposto allo stub, il test che riscontra sulla pelle eventuali tracce di sparo, ma – si era anche detto – ancora si attendevano gli esiti degli esami peritali. Nulla di più.
In quell’occasione la giornalista aveva notato l’assenza di Zorzon. Per lei il capo della Mobile era sempre stato un osso duro da rodere. Un tipo difficile, diverso dagli altri poliziotti che aveva conosciuto in precedenza, perché si era dimostrato un soggetto poco abbordabile. Non che Zorzon si comportasse mai con scortesia oppure in modo scostante con la stampa, tuttavia era sempre molto professionale nei rapporti con i cronisti, che tendeva sempre a limitare al minimo essenziale. Era un uomo ruvido dentro che non si lasciava mai andare a eccessive confidenze.
La pervicace giornalista di nera optò quindi per il “piano B”, cioè il sondaggio informale dei militari dell’Arma, ritenendo sicuramente più agevole un contatto col colonnello Borlacco. Con lui aveva una certa familiarità e, cosa più importante, possedeva il numero del suo cellulare privato. Fece dunque mente locale sulla scaletta di argomenti che avrebbe voluto affrontare.
«Pronto! Buongiorno, è lei colonnello? La disturbo? Sono Mara Maritan, potrei farle qualche veloce domanda?»
Prima di risponderle Borlacco impartì ad alta voce alcune disposizioni a un carabiniere che si trovava nei suoi pressi, poi mutò tono e divenne più cortese, pur senza riuscire a celare del tutto il suo fastidio per quella telefonata.
«Dottoressa carissima, ma noi non ci davamo del tu …o sbaglio?»
Ritenendo di aver fatto breccia nell’ufficiale, la Maritan con fare di circostanza gli pose una richiesta a bruciapelo.
«E certo! Ciao colonnello. Ascolta, omicidio Calegaro: io sono qua sotto in macchina, ci vediamo solo per un attimino? Ti offro un caffè al volo e facciamo due chiacchiere. Dai, ti prego, poi non ti rompo più le scatole fino a domani… promesso!»
Borlacco l’avrebbe mandata volentieri al diavolo, ma dovette sforzarsi per mantenere il controllo e non debordare nel turpiloquio.
«Amore mio, ma come faccio… che non lo vedi come stiamo combinati. Eppoi tra mezz’ora ciò pure la riunione col generale comandante che viene apposta da Udine. Che vuoi che ti dica, fino a quando non andrò al summit in Procura neanche io ne saprò nulla».
La Maritan incalzò l’ufficiale inchiodandolo ancora per alcuni secondi all’apparecchio.
«Dai, solo qual cosina. In questura gira voce che siano coinvolte organizzazioni mafiose slave, lo indicherebbero le modalità dell’esecuzione: che ruolo potrebbe aver rivestito nel caso di specie il marocchino?»
Borlacco le concesse ancora qualche secondo preparandosi a liquidarla con una scusa. Ma per farlo dovette iniziare a parlare il suo stesso linguaggio, assecondandola con risposte generiche e assolutamente scontate.
«Gli slavi!?! Ma chi te le racconta ste’ storie! Io non lo so guarda… Per quanto riguarda il marocchino non sono ancora in condizioni di affermare nulla di certo. Tutto può essere. Lo sai meglio di me che in questo benedetto Paese nessun luogo è più sicuro ormai. Ma questo non vuole necessariamente dire che l’omicidio del Meduna vada ricollegato a dinamiche mafiose. Vabbene adesso? Poi non andate a dire che non aiutiamo la stampa, eh…»
La Maritan rilanciò.
«Quindi non escludete nessuna pista, potremmo trovarci di fronte a una fase di recrudescenza criminale in regione…»
A questo punto, davvero infastidito, Borlacco perse la pazienza e tagliò corto.
«Allo stato attuale non posso dirti niente, si tratta solo di illazioni e nulla di più. Dobbiamo risentirci più avanti, perché adesso devo proprio lasciarti. Prova a richiamarmi domani. Ciao!»
***
In questura Jaffna continuava a protestarsi innocente. Ripeteva come un disco rotto che quella sera lui non era a Spilimbergo bensì a Udine, inoltre di essere rimasto in quella città fino al giorno seguente, ospite nella camera in affitto di un suo connazionale che lavorava in una pizzeria di viale Ledra. Ammise di essersi recato a Pordenone, ma soltanto il giorno dopo e allo scopo di incontrare il suo complice che gli avrebbe fornito la carta d’identità rubata da vendere poi agli egiziani di Mestre.
In effetti le sue dichiarazioni in parte corrispondevano alla verità, poiché da un controllo effettuato sui tabulati telefonici era risultato che le celle agganciate la sera dal delitto dal suo cellulare erano quelle della zona centrale del capoluogo friulano. Ma questo dimostrava esclusivamente che quell’apparecchio due ore prima dell’omicidio aveva chiamato dal centro verso un altro cellulare nella stessa città, tuttavia nessuno avrebbe potuto confermare che quello stesso cellulare in quel preciso momento fosse nella diretta disponibilità di Jaffna. In ogni caso, anche se a quell’ora il marocchino si fosse realmente trovato a Udine, avrebbe comunque avuto tutto il tempo per recarsi fino a Tauriano.
Anche i possibili moventi permanevano oscuri. I contrasti derivanti dalla prestazione sessuale erano un’ipotesi suggestiva che non andava scartata a priori, in fondo Nevio Calegaro era noto per essere uno sbrigativo nel passare alle vie di fatto, però si correva il rischio di applicare ai soggetti coinvolti nella vicenda un cliché, riducendoli nella stretta gabbia delle loro pulsioni personali.
I tentativi del giovane di convincere poliziotti della propria innocenza si fondavano sulla sabbia: il suo alibi non reggeva, inoltre si era posto in una pessima luce per via della sua ostinazione nel non voler rivelare l’identità del proprio complice. Venne trattenuto in stato di fermo. Oltre ai gravi indizi per l’omicidio, a suo carico c’erano anche i reati di ricettazione e violazione della legge sull’immigrazione.
(3 – continua)