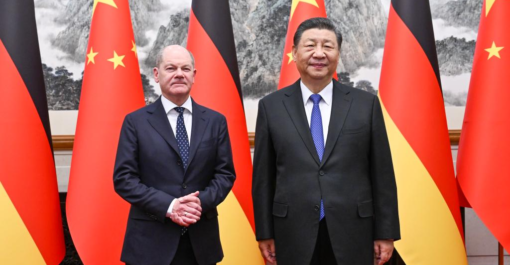di Fracensco Orofino (segretario generale In/Arch-Istituto nazionale di architettura) – Mi permetto di avanzare una proposta per la task force guidata da Vittorio Colao (considerato, tra l’altro, che al suo interno non ha nessun esponente del mondo dell’architettura e delle costruzioni) in vista della «rinascita» della fase due o tre, o non so quale: avviare un grande programma di edilizia residenziale pubblica per la fasce deboli della popolazione.
Non so come cambierà il nostro sistema di sviluppo nei prossimi anni, come muteranno le città, quale modello economico si affermerà dopo questi eventi, ma so che tra le conseguenze di questa crisi sanitaria e del lockdown del sistema economico-produttivo ce n’è una particolarmente preoccupante: l’acuirsi delle diseguaglianze sociali e l’aumento di cittadini italiani in condizioni di povertà assoluta e relativa.
La crisi del coronavirus, d’altra parte, si innesta in uno scenario mondiale di disparità nella distribuzione della ricchezza già molto allarmante e peggiorato progressivamente negli ultimi anni.
L’Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) ha calcolato che tra giugno 2018 e giugno 2019 nel mondo l’1% di popolazione più ricco, sotto il profilo patrimoniale, deteneva più del doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone.
Nel nostro Paese – sempre secondo Oxfam – il 10% più ricco possedeva oltre 6 volte la ricchezza del 50% più povero. Una quota cresciuta in 20 anni del 7,6% a fronte di una riduzione del 36,6% di quella della metà più povera degli italiani.
Nel 2019 la quota di ricchezza in possesso dell’1% più ricco degli italiani superava quanto detenuto dal 70% più povero, sotto il profilo patrimoniale.
Non è difficile comprendere come, in un sistema così squilibrato, la caduta dei redditi di questi mesi, la perdita di migliaia di posti di lavoro, le difficoltà dovute al distanziamento sociale rischia di rendere la situazione esplosiva.
Pensiamo alla realtà dei lavoratori precari, cresciuti in modo esponenziale in questi anni, delle persone con contratti a termine o a chiamata, di chi vive di economia informale, della grande massa di lavoratori autonomi.
Questa crisi rischia di riflettersi pesantemente anche sulla condizione abitativa delle fasce deboli di popolazione, aggravando, anche in questo caso, un’emergenza già molto preoccupante in numerose città italiane prima della pandemia.
In questi mesi di permanenza forzata nelle abitazioni è emerso in tutta la sua crudezza il disagio di chi è costretto a vivere 24 ore in case piccole e inadeguate. Per molti la casa non è stata un comodo rifugio ma un luogo opprimente.
È necessario chiedersi quante famiglie saranno presto a rischio di sfratto per morosità avendo perso le risorse per sostenere i canoni di affitto e quante rischiano di perdere la casa di proprietà perché impossibilitati a onorare il proprio mutuo.
Sappiamo che in Italia gli impegni finanziari dedicati al “diritto all’abitare” e all’edilizia sociale pubblica negli ultimi trent’anni sono stati bassissimi.
Siamo da molto, troppo tempo, il paese europeo che spende meno in questo settore.
Il Pil impiegato attualmente dallo Stato italiano per la costruzione di alloggi popolari è intorno allo 0,02 per cento, mentre la media europea è del 3 per cento.
In Europa un quinto delle famiglie vive in un alloggio sociale, in Italia solo il 3,5 per cento.
Le 700.000 famiglie che occupano gli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica, n.d.r.) sono appena 1/3 di chi ne ha veramente bisogno. L’offerta abitativa pubblica in Italia, dagli anni Ottanta si è ridotta del 90 per cento.
Per tutte queste ragioni propongo a chi ha la responsabilità di programmare gli interventi per la “ripresa” di avviare un piano di investimenti per edilizia residenziale pubblica e che tale piano debba essere considerato, accanto all’impegno per una migliore sanità pubblica o per più servizi sociali, una componente essenziale per un nuovo welfare in grado di diminuire precarietà e povertà.
Non solo quindi risorse per le opere infrastrutturali, pur estremamente necessarie e urgenti.
Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica disponibile non basta e non basterà per dare risposte a chi si troverà in situazioni di disagio abitativo e occorre essere consapevoli che i “timidi” tentativi di social housing sperimentati in questi anni e affidati principalmente a promotori privati, non sono e non saranno sufficienti.
Sono ancor più convinto che il problema della casa sociale debba tornare al centro della riflessione della cultura architettonica italiana e, più in generale, del mondo delle costruzioni.
Molti prefigurano per il dopo crisi una “economia da dopoguerra”. Possiamo allora guardare a una nostra storia non molto remota, legata, appunto, alla “ricostruzione” post bellica.
Nel 1949 il Parlamento italiano approvò il progetto di legge voluto dall’allora ministro del Lavoro Amintore Fanfani, denominato «Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori», più comunemente noto come Piano Ina Casa.
Quel piano consentì a migliaia di famiglie di migliorare la propria condizione abitativa e contemporaneamente di offrire una risposta efficace al problema della disoccupazione.
Fu uno degli interventi più significativi della politica economica e sociale del nostro paese nel dopoguerra.
Il piano consentì la realizzazione di circa due milioni di vani, offrendo una casa in affitto a basso costo a oltre 350.000 famiglie italiane, tra le quali moltissime di “immigrati” dalle nostre campagne e dal Mezzogiorno d’Italia.
Per gestire questo complesso intervento furono create due strutture che “centralizzarono” l’intero sistema di gestione e controllo: un comitato di attuazione del piano diretto da un ingegnere, Filiberto Guala, e la Gestione Ina-Casa, responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti architettonici e urbanistici, guidata dall’architetto Arnaldo Foschini, preside della facoltà di Architettura della capitale.
All’interno della Gestione Ina-Casa fu istituito un Ufficio architettura, la cui direzione fu affidata da Foschini all’architetto Adalberto Libera.
In quell’occasione l’architettura Italiana compì uno sforzo straordinario di ricerca sui temi dell’abitazione, del miglioramento dello spazio abitabile, della città e della sua pianificazione, del concetto di quartiere.
Ma soprattutto, a mio parere, vi fu uno impegno disciplinare per offrire risposte al bisogno di “una casa per tutti”, riconquistando un ruolo e una responsabilità sociale per la figura del progettista.
Scriveva Foschini a proposito del piano Ina-Casa: «La vastità del programma edilizio di questo piano richiede un particolare senso di responsabilità. Si tratta (…) di dare all’abitazione un aspetto lieto e accogliente, oltre a una perfetta funzionalità; si tratta infine di contribuire con i complessi edilizi che verranno creati, a raggiungere quell’armonia architettonico-urbanistica che è sempre stato vanto del nostro paese nei secoli scorsi, quando si curavano in sommo grado non soltanto i centri monumentali, ma anche i centri più modesti».
Oltre a bandire numerosissimi concorsi di architettura (soprattutto nei primi sette anni del Piano) per la scelta dei migliori progetti, la Gestione Ina-Casa produsse un significativo contributo scientifico sul tema dell’abitare, pubblicando diversi manuali con orientamenti, schemi, esempi, soluzioni tecnologiche che contribuirono a migliorare lo standard delle realizzazioni.
Guardando a quell’esperienza e al bisogno che abbiamo oggi di una ricostruzione sociale, pur in assenza di macerie fisiche, occorre avviare presto un nuovo grande piano di edilizia popolare, investendo per esso risorse significative.
Risorse molto più ampie del miliardo di euro proposto dal ministro delle Infrastrutture De Micheli e inserito nella legge finanziaria 2020 per «migliorare la qualità dell’abitare, con la rigenerazione degli edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i cantieri nei piccoli comuni».
Naturalmente oggi il tema non andrebbe più coniugato in termini di creazione di nuovi quartieri, nuove periferie, nuovo consumo di suolo.
La necessità di dotare ampia fasce di popolazione di edilizia sociale deve oggi confrontarsi con i temi della rigenerazione urbana, del riuso e riqualificazione dell’ingente patrimonio immobiliare pubblico e privato dismesso, di una produzione edilizia ispirata alla sostenibilità ambientale e sociale ed all’efficienza energetica, della rivitalizzazione delle aree interne del Paese e dei borghi disabitati.
Un piano per la casa che sappia anche offrire nuove risposte ai problemi dell’accoglienza e dell’integrazione di nuovi lavoratori immigrati, spesso vittime di un disagio abitativo tra i più estremi.
In sostanza un intervento del soggetto pubblico, come fu per il piano Fanfani, in grado di orientare le politiche di rigenerazione delle nostre città e dei nostri territori e di attuare, concretamente (e finalmente) quanto previsto dalla Risoluzione dell’Unione europea del 2001 che invitava gli Stati membri «a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica».
Un programma di investimenti in welfare abitativo gestito senza grovigli di competenze, organismi e soggetti ma con sistemi di controllo e organizzazione centralizzati e qualificati, affiancati da un organismo scientifico in grado di dare qualità alle progettazioni, di organizzare e indire concorsi veri di architettura, di offrire contributi disciplinari seri per garantire alti standard di qualità.
Un piano di edilizia sociale pubblica ha assoluto bisogno del contributo del mondo dell’edilizia e, soprattutto, della cultura architettonica.
Sarebbe una occasione per tornare a riflettere sulla casa sociale, sulle soluzioni tipologiche e distributive, sulla casa a basso costo, sulle tecnologie innovative, sul rapporto tra casa e città, su nuovi modelli sostenibili del costruire.
Oggi, dopo aver constatato la frequente inadeguatezza delle nostre abitazioni di fronte al prolungato e imposto #iorestoacasa, dopo aver sperimentato i nuovi bisogni legati allo smart working, eccetera.
Quando si parla di casa si ha l’impressione che si continui a progettare con schemi e soluzioni ferme alle elaborazioni degli anni Cinquanta del secolo scorso o ai manuali di Diotallevi e Marescotti e simili.
La riflessione sulla casa popolare, ahimè, è stata abbandonata da anni dal dibattito architettonico contemporaneo, troppo a lungo “distratto” dalle prestazioni spettacolari di grandi edifici muscolari e autoreferenziali, con budget esorbitanti, espressione simbolica della globalizzazione e del predominio dell’economia finanziaria.
Nel 1949 le migliori menti dell’architettura Italiana seppero offrire un contributo reale ad un Paese in ginocchio dopo il disastro della guerra: si impegnarono in prima persona per offrire risposte al bisogno di case per i più poveri e di case a basso costo.
Forse è giunto il momento di tornare a lavorare su questi temi, a sperimentare e innovare per offrire soluzioni ai più deboli della società. E a ridare così un ruolo sociale (e meno marginale) all’architettura.