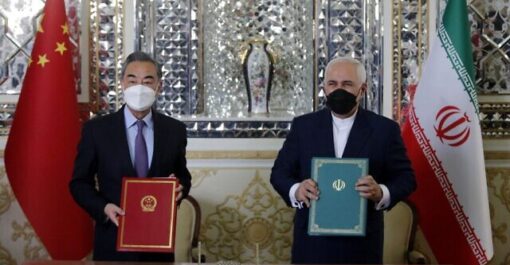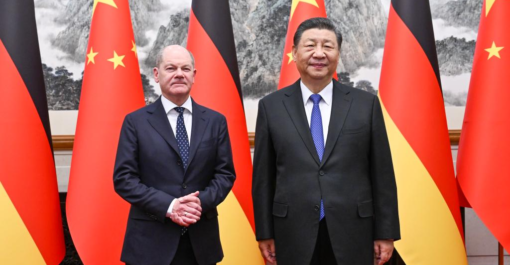28 ottobre: derby di sangue! È la storia di alcuni ragazzi, cinque giovani che come tanti altri, in quel periodo folle che furono gli anni Settanta, si aggregarono a uno dei gruppi di tifosi ultras delle due galassie, la romanista e la laziale, allora attive nel tifo organizzato delle squadre di calcio della capitale.
È una storia vera, tratta dal libro di racconti “A Kabul con un dollaro: da Spilimbergo all’Afghanistan le storie disordinate di un reporter senza quattrini”, scritto da Gianluca Scagnetti e pubblicato alcuni anni fa.
Il preludio alle violenze che quella piovosa mattina di autunno, in una città resa ancora più plumbea dall’ombra nera del terrorismo, sarebbe culminato in tragedia.
Grande battaglia quella attesa per oggi nelle strade della capitale. Fin dal primo mattino sparute pattuglie di eroi negativi dei nostri tempi si spostavano per le vie della città. Ognuna di esse diretta verso un particolare punto di concentramento. Lì si sarebbero aggregate al grosso della forza per dirigersi poi nel luogo dell’epico scontro.
Strano gruppetto quello formatosi da poco al quartiere Portonaccio: quattro giovani di estrazione sociale alquanto diversa, ma uniti dalla medesima fede, la squadra di calcio del cuore.
Hanno dai quindici ai diciassette anni ed esteriorizzano la loro appartenenza al gruppo attraverso il loro inconfondibile modo di abbigliarsi: scarpe da ginnastica, blue jeans e giacca mimetica da paracadutista.
Ne fanno parte il diciassettenne Reiner Colaut e i suoi amici. Ivan è quello al quale è più attaccato, un giovanottone bruno di capelli figlio di un tipografo iscritto al Partito comunista, ma dalle idee politiche diametralmente opposte a quelle di suo padre.
Fabiano invece è un fricchettone, è di animo buono e ha un discreto successo con le ragazze, tuttavia è il più stupido del gruppo, poiché agisce impulsivamente e quindi combina spesso cretinate. È l’unico capellone del gruppo, ha una chioma stoppacciosa bionda ossigenata che esibisce ogni sabato in discoteca al Piper di via Tagliamento.
Marko è il più piccolo. Ha quindici anni ed è quello che potrebbe definirsi un figlio di papà. Dagli amici del suo quartiere, Monteverde, si fa chiamare «Attila», un soprannome affibbiatosi da solo perché gli piaceva. Capelli rasati a zero allo scopo di entrare meglio nella parte del “cattivo”, agli altri ripete ossessivamente sempre la stessa domanda: «Faccio paura vero? Di la verità, faccio più paura così che col passamontagna calato in faccia eh?»
Malgrado il terribile nome di battaglia Marko è un bravo ragazzo proveniente da un’ottima famiglia. Nato all’Asmara quando l’Eritrea faceva ancora parte dell’Etiopia, nell’ex colonia italiana i suoi genitori risiedevano dagli anni Trenta, ma nel 1975 dovettero fuggirvi via tutti perché nel Paese allora si versava troppo sangue.
C’era stato il colpo di stato del colonnello Menghistu Hailè Mariam, l’ufficiale sostenuto dall’Unione sovietica aveva deposto il negus Haile Selassie.
Giunta in Italia, la sua famiglia si era definitivamente stabilita nell’ampio e lussuoso appartamento di proprietà ai Colli portuensi. A Roma Marko si era re-iscritto a scuola e adesso frequentava uno dei migliori licei linguistici della città. Appassionato di calcio, aveva iniziato a seguire le partite della squadra della Roma, unendosi ben presto ai gruppi del tifo organizzato della Curva Sud.
Fu proprio allo stadio che conobbe gli altri, avvenne a Pian di Massiano, alla fine di un incontro tra il Perugia e la Roma terminato nel fumo tossico dei lacrimogeni lanciati dalla Celere.
Infilatosi casualmente in uno dei numerosi pullman della carovana di tifosi giallorossi in trasferta, che si trovava in sosta con i motori accesi in procinto di partire per il viaggio di ritorno.
Non aveva i soldi per pagare il biglietto del treno e allora si era imbucato a bordo, ospitato dalle Sag, le Squadre di azione giallorosse, formazione ultrà che raccoglieva i suoi membri nei quartieri Tiburtino e Nomentano.
«E oggi?»
Chiese a un tratto lo stralunato Fabiano, ottenendo immediatamente la risposta di Ivan, capo indiscusso del gruppo.
«Oggi sarà una giornata particolare, vedrete che casino quando incontreremo i Laziali a Piazza Istria».
Erano le sette e mezza della mattina, il cielo era grigio piombo e cominciava a piovere. I primi bar stavano pigramente aprendo i battenti, mentre le rivendite dei giornali lo avevano fatto già da almeno un’ora. Era domenica, e tutti cercavano di riposare qualche minuto in più nei loro letti, soltanto in seguito, e con estrema calma, avrebbero iniziato a vivere quella giornata festiva.
Ma non tutti in quella domenica d’autunno nella quale tutto procedeva con lentezza avevano voglia di oziare. Certamente non la pattuglia di teppisti delle Sag, usciti presto di casa per andare a cercare rogne.
28 ottobre derby di sangue! Fu questo l’inquietante violento messaggio scritto su un muro in stampatello maiuscolo da Reiner con la bomboletta di vernice spray di colore bordeaux.
Un funesto presagio si sarebbe potuto affermare in seguito, poiché in quella stessa giornata, poche ore più tardi, allo stadio un tifoso della Lazio seduto sugli spalti della Curva Nord sarebbe stato colpito a morte da un razzo antigrandine sparato da un rudimentale tubo di lancio da alcuni teppisti della squadra avversaria.
Ma alle sette e trenta del mattino il gruppetto di guerriglieri della domenica che si era dato appuntamento a Casalbertone non avrebbe potuto immaginare neppure lontanamente quello sarebbe accaduto.
Roma-Lazio, partita “di cartello” di quella giornata del girone di andata del campionato di serie A, avrebbe avuto inizio soltanto alle quindici, tuttavia, il rituale ludico degli ultras imponeva l’azione, la più eroica, fin da subito.
In qualche modo i Romanisti erano venuti a conoscenza del fatto che una parte degli Eagles Supporters, la formazione ultras “nemica” si sarebbe data appuntamento alle nove al quartiere Trieste. Da lì, dopo essersi uniti agli altri gruppi ultras biancoazzurri che li attendevano sul grande piazzale antistante la Curva Nord, avrebbero poi fatto ingresso allo stadio.
A Piazza Istria, luogo del primo appuntamento, i Laziali dei quartieri limitrofi – Africano, Trieste e Salario – avrebbero portato con loro lo striscione.
«Lo striscione portano i bastardi? – esclamo in slang romanesco Ivan rivolgendosi agli altri – Je lo dovemo fregà eppoi je damo ar fogo!»
Il picchiatore alle prime armi proseguì quindi a illustrare il piano d’azione elaborato nei giorni precedenti dai capi della curva.
«Piazza Istria ha soltanto cinque uscite, se noi le blocchiamo tutte e poi li circondiamo ce la possiamo fare. Però dobbiamo essere in tanti, altrimenti i bastardi ce rovineno de botte…»
Malgrado il piglio deciso da leader, Ivan era ancora un ragazzino e le notizie relative al colpo di mano di Piazza Istria le aveva carpite involontariamente ai capi della Curva Sud, poiché quelli non lo avevano fatto partecipare alla elaborazione del piano di attacco.
Però, il fatto di poter strappare un pezzetto di striscione del nemico lo entusiasmava. Un brandello di tela azzurra recante la traccia di una lettera scritta con la vernice bianca, un brandello, sia pur di ridottissime dimensioni, da conservare come un feticcio. E il resto al rogo!
Sai che vergogna per i Laziali, pensarono i quattro mentre l’autobus della linea 409, semivuoto, li stava trasportando alla Stazione Tiburtina.
Dal finestrino della piattaforma posteriore Fabiano, armato di fionda, si divertiva a scagliare bulloni contro i cristalli delle macchine parcheggiate in Via di Portonaccio, venendo però severamente rimproverato da Ivan.
«Falla finita brutto deficiente! – gli gridò perentoriamente – Così ci beccano a tutti, coglione! …che non lo sai che abbiamo la roba dietro!?!»
Col termine «roba» Ivan si riferiva all’armamentario specifico dell’ultras per la guerriglia urbana: Fabiano si era portato dietro la fionda e i bulloni, Reiner le bombolette di vernice per scrivere sui muri e Marko la pistola lanciarazzi.
Ivan al contrario non recava con sé armi improprie, non ne aveva certo bisogno. Alto un metro e ottanta, da due anni praticava il pugilato presso la palestra Audace di Via Frangipane. Insomma, era uno che quando picchiava ci andava giù di brutto.
Prima di raggiungere lo Stadio Olimpico avrebbero fatto tappa a Piazza Bologna, dove avrebbero incontrato il resto delle Sag. Gli altri erano in possesso dei razzi e dell’accessorio necessario per spararli con la pistola di Marko, cioè il bicchierino, quel supporto che si avvitava alla bocca della scacciacani, sede e camera di innesco del razzo luminoso.
«Messi come stamo chi cè viene a rompe er cazzo…», commentò compiaciuto Ivan riferendosi alla panoplia che disponevano.
Appuntamento alle otto in punto a Piazza Bologna dunque, poi, discretamente, si va tutti insieme ad assaltare i Laziali a Piazza Istria, basterà prendere l’autobus numero 6.
Ma i teppisti non sono i commandos dello Special Air Service, al contrario si comportano spesso da stupidi e, siccome non sono per niente gerarchizzati, a volte divengono anche incontrollabili. E i lanci di bulloni di Fabiano dal finestrino dell’autobus lasciavano prevedere un esito quasi scontato dell’azione delle Sag.
Da questo momento in avanti i quattro ragazzi della banda non controlleranno più gli avvenimenti, ma saranno da essi influenzati. Tutto si consumerà in tempi brevissimi, in una frazione infinitesimale di quella domenica che loro pensavano ancora di concludere insieme in birreria nel tardo pomeriggio, dopo avere assistito alla partita di calcio.
Piazza Bologna, ore otto. In giro per strada non c’è quasi nessuno. Gli altri delle Sag non si sono ancora fatti vivi e continua a piovere.
Cosa si fa? Si entra nel Caffè Santarelli e si ordina un cappuccino e ci siede al coperto riparandosi dal maltempo? Sarebbe la soluzione migliore invece che restare a inzupparsi come degli imbecilli ad aspettare l’arrivo degli altri.
E invece no. In un attimo fabiano incominciò a prendere a calci un vecchio ciclomotore Garelli legato con la catena e il lucchetto a un lampione. Rise gasato Fabiano mentre distruggeva il motorino, assalito da una forza incontenibile.
«Dai, dai… sfasciamo tutto! Sfasciamo tutto!», esclamò provocando l’intervento di un serioso Ivan.
«Ma de chi è sto’ cesso de motorino? Che o’ conosci er padrone?»
«Ma che cazzo te frega… – replico l’invasato Fabiano – annamo, rompemo sto’ pezzo de fero!». In un attimo tutti tranne Ivan si accanirono contro l’incolpevole ciclomotore.
Una volta distruttolo, Marko indicò col dito la cabina fotografica. Quattro scatti mille lire, quattro calci specchio rotto. Fu proprio lui a dare la stura strappando con violenza la tendina ocra che faceva da paravento alla cabina, la tirò via con tale forza da staccare persino gli anelli metallici che la tenevano agganciata.
Gli altri fecero il resto prendendo a calci le pareti in formica spaccandole. Reiner firmò l’azione scarabocchiando con la vernice spray il cartello delle istruzioni: SAG, laziali per voi derby di sangue! Grossomodo il medesimo slogan che caratterizzò quella domenica da dimenticare.
Però, il frastuono provocato nel danneggiare la cabina telefonica attirò l’attenzione della gente, i pochi passanti e qualche residente che si mise dietro la finestra di casa a osservare la scena che gli si presentava sotto casa, pensando fosse che si trattasse della solita violenza politica, frequente in quegli anni in quella piazza frequentata da neofascisti.
Il custode dello stabile di Via Michele Di Lando si affacciò da portone, era un omino sulla sessantacinquina prossimo alla pensione che vestiva sempre alo stesso modo. I ragazzi delle Sag lo conoscevano di vista e non gli era mai piaciuto, un sentimento tuttavia reciproco.
«A regà damose, che quer marchiciano de merda der portiere chiama e ‘ guardie!», urlò Ivan a fabiano, ancora intento a sfasciare la cabina fotografica.
Il gruppetto si diede alla fuga di corsa giù per Via Livorno. A quest’ora della domenica per strada non ci sarà nessuno – pensarono – e la loro speranza era quella di trovare un portone aperto per infilarcisi dentro fino a quando, più tardi, il quartiere non si fosse popolato e, dunque, una volta fuori non avrebbero dato nell’occhio.
«Entriamo in chiesa! Entriamo dentro!», gridò Marko indicando la chiesa di Sant’Orsola. Non era però possibili, lì dento vestiti in quel modo li avrebbero individuati subito tutti e quattro, e magari le suore avrebbero fatto pure la spia ai poliziotti.
Giunti all’angolo con Via Giuseppe Pitrè percepirono chiaramente il segnale che gli annunciava l’inizio dei guai veri. Si trattava del rumore del motore di un’autovettura, l’inconfondibile rombo di un’Alfa Romeo, quasi sicuramente indice della presenza in zona di una pantera della Polizia o di una gazzella dei Carabinieri.
«Le guardie, cazzo! – esclamò Ivan con una smorfia che gli sfigurò il volto – So già arivate! È stato quell’infame der marchiciano a chiamalle…»
Sì, era stato il portinaio, che spaventato dai teppisti scatenati aveva fermato una pattuglia della Polizia in transito al quartiere Nomentano.
Per non farsi vedere dagli agenti, i quattro si accucciarono dietro ad alcune automobili in sosta lungo Via Livorno. La pantera della Mobile percorse lentamente tutta la strada, ma gli uomini dell’equipaggio che si trovavano a bordo non riuscì a scorgerli e, arrivata in fondo alla discesa, all’incrocio con Via Apuania svoltò repentinamente a destra passando col semaforo rosso.
«Salvi… quelli se ne vanno al commissariato di Via Chianti» disse piano Reiner.
Sovrapponendo la sua voce a quella dell’amico, Ivan soggiunse: «Togliamoci da dosso le mimetiche e andiamocene verso Via Nomentana passando da dietro le stradine».
È fatta – pensarono -, se non facciamo più casino riusciremo ad allontanarci da qui e raggiungeremo gli altri a Piazza Istria.
Ma senza dare loro tregua, in un istante sopraggiunse un’altra macchina, stavolta del locale commissariato, che risalì anche lei lentamente Via Livorno provenendo dalla Circonvallazione Nomentana.
I quattro rimasero impietriti. Improvvisamente, fari abbaglianti accesi, l’agente alla guida della Fiat 128 con i colori d’istituto della Polizia ingranò la marcia più bassa puntando dritto contro di loro.
Il motore millecento di cilindrata s’imballò, i pneumatici stridettero lasciando nell’aria un fastidioso puzzo di gomma bruciata. In una frazione di secondo raggiunse il gruppo di teppisti inchiodando davanti a loro.
l’agente seduto al posto del capomacchina scese dall’autovettura mentre questa era ancora in corsa e, pistola alla mano, intimò l’alt ai quattro.
«Fermi bastardi!»
Ivan, che frequentava la zona, riconobbe subito i due poliziotti, erano “Serpico” e Lambrotta, due dei più rigidi del commissariato Sant’Ippolito.
«Fermi tutti con le mani contro il muro!» Urlò nervoso Lambrotta con una inflessione dialettale che tradiva le sue origini casertane. «Siete armati? Siete armati o no?»
Non fece in tempo a terminare la frase che Marko, preceduto dagli altri e dunque più indietro rispetto al gruppo, inaspettatamente scappò.
Cominciò a correre col fiato spezzato dalla paura su per Via Livorno in direzione di Piazza Bologna. Non sapeva dove andare, però scappava. Era terrorizzato dal fatto di avere in tasca la pistola lanciarazzi, conosceva bene le conseguenze di quella situazione, se applicavano la Legge Reale si beccava una pena dura.
Un ragazzino immaturo e spaventato, non più in condizioni di riflettere su cosa gli sarebbe convenuto fare. La decisione più semplice e immediata era quella di scappare correndo a perdifiato
Ce la faccio, cela faccio… – pensò -, il poliziotto è appesantito, e inoltre è costretto dall’uniforme. Non solo, ha pure le scarpe con la suola di cuoio, mentre io calzo quelle di gomma. Ce la faccio….
La reazione degli agenti, però, fu molto dura. Serpico alzò la ribalta della sua fondina ed estrasse la pistola. Lambrotta, che la Beretta già l’impugnava, la puntò dapprima in aria e poi contro il fuggitivo, intimandogli nuovamente di fermarsi.
«Fermo pezzo di merda! Fermo o sparo!»
Richiamata dall’insolito trambusto proveniente dalla strada sotto la sua abitazione, un’inquilina che abitava al primo piano si affacciò alla finestra sporgendo fuori il capo.
Fu proprio in quel mentre che Lambrotta aprì il fuoco.
Bam! Bam! Bam! Tre colpi calibro nove parabellum, poi ancora altri due, i secondi in direzione di Marko.
«Mio Dio! Che fa, è impazzito? Così lo uccide…» esclamò terrorizzata la donna.
«Dentro! – replicò infuriato Lambrotta – Si faccia i cazzi suoi e chiuda la finestra, ha capito signora!?!»
La donna non ci pensò due volte, ritirò immediatamente il capo e tirò giù velocemente la persiana.
Nel frattempo Serpico si stava dedicando agli altri tre componenti del gruppo, immobilizzati di fronte alla tabaccheria all’angolo. A seguito di una sommaria perquisizione dei tre ragazzi uscirono fuori bulloni, fionda, e bomboletta spray di vernice.
«Che cazzo sono questi, eh?» urlò il poliziotto «Forza! Veloci, datemi i vostri documenti, che io adesso prendo la macchina e vado ad arrestare quel figlio di puttana dell’amico vostro e poi ritorno qua. E se voi solo vi spostate di un centimetro io vi spacco le gambe, chiaro!?!»
I tre consegnarono le carte d’identità al poliziotto, che se le portò dietro in macchina. Salito al posto di guida parti sgommando per raggiungere il suo collega che stava inseguendo Marko.
Una volta allontanatosi a Fabiano venne l’idea di disfarsi dei bulloni e del resto del materiale che Serpico gli aveva trovato addosso. Prese tutto quello che stava per terra e lo gettò nella cassetta postale a muro che si trovava vicino alla tabaccheria.
«Ma che fai imbecille!?! – lo rimproverò Reiner – Serpico ormai te le ha viste, che le butti a fare? Adesso quando tornerà sarà peggio!»
Nulla da fare, Fabiano, lacrimando continuò imperterrito a disfarsi della roba, che adesso costituiva corpo di reato.
In pochi minuti sopraggiunsero sul posto altre quattro volanti, poi passò anche un’Alfa 1750 grigia della Guardia di Finanza. I tre si interrogarono sul destino di Marko: sarà riuscito a scappare? Dove potrà mai nascondersi?
Il cerchio degli inseguitori si stava stringendo sempre più attorno a lui. Decise allora di disfarsi della pistola. Afferrò la lanciarazzi che aveva in tasca e la gettò in un cestino metallico dei rifiuti, ma da dietro Lambrotta se ne accorse.
Il ragazzo disponeva ancora di un certo margine di vantaggio sul poliziotto. Girò a destra per Piazza Lotario, quindi attraversò Via Giacomo Boni, da dove raggiunse poi Viale XXI Aprile, una strada molto larga che a quell’ora della domenica era semideserta.
Lì c’era la Caserma Piave, sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, ma Marko, che proveniva da un quartiere dall’altro lato della città non poteva certo saperlo.
Corse ancora avanti. Uno dei pochi passanti lo fermò afferrandolo per un braccio. «Mi dici che ore sono per piacere?», gli chiese. Era evidente che si trattava di un pretesto per rallentare la sua fuga per mettere gli agenti che lo stavano inseguendo nelle condizioni di arrestarlo.
Marko non gli prestò attenzione, lo strattonò e riprese a correre nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura. Percorse altri duecento metri, Lambrotta era ancora dietro, ma ecco che dalla Caserma Piave usci un finanziere che lo bloccò.
Il militare era corpulento e sbatté a terra Marko come in un placcaggio durante un incontro di rugby.
Era finita. Sopraggiunse Lambrotta, poi, nel giro di alcuni secondi anche un’Alfetta della Polizia. Gli agenti delle volanti stavano per caricarlo in macchina, ma un ansimante Lambrotta lo prese per il bavero della giacca mimetica e gli sbatté sulla faccia la scacciacani che aveva recuperato dal cestino dei rifiuti.
«E questa che cazzo è!?! Rispondi stronzo!»
Marko iniziò a piangere.
Intanto Serpico aveva già fatto ritorno in Via Livorno dagli altri tre. Sceso dalla macchina chiese a Fabiano dove avesse messo la roba. Quest’ultimo per tutta risposta incominciò a tergiversare piagnucolando. «Non lo sooo…»
Serpico perse definitivamente la pazienza.
«Che li hai buttati? Disgraziato, delinquente, stronzo! – gli urlò – Mo’ ti faccio vedere io che succede a pigliarmi per il culo…»
Il poliziotto introdusse le mani all’interno della cassetta postale piena di corrispondenza, ma, esercitando una eccessiva pressione ne provocò l’apertura del fondo e le buste e le cartoline che si trovavano al suo interno caddero tutte sul marciapiede bagnato e con loro anche la fionda e i bulloni.
«Mo’ mo’, so’ cazzi tuoi… vedrai adesso quando arriviamo al commissariato».
«Fatemeli vedere in faccia a questi stronzi!», esclamò il maresciallo del turno della mattina mentre a uno a uno i giovinastri fermati fecero ingresso negli uffici del commissariato Sant’Ippolito. Marko, che era stato ammanettato, fu il primo della fila.
Tre dei quattro vennero fatti sedere su di una panca di legno all’interno di una stanza dalle finestre chiuse, illuminata soltanto da una lampada al neon verdastra incastonata in una plafoniera “standard”.
Come fabiano varcò la soglia, Serpico lo colpì con un ceffone, facendolo ricominciare a piangere.
Marko venne separato dagli altri, fatto sedere nella stanza dove in quel momento si trovava il maresciallo. Anche lui si abbandonò alle lacrime, protestando disperato la sua innocenza. Si rivolse a Fabiano, che era nell’altra stanza con gli altri. Le porte erano state lasciate aperte, e tra loro potevano parlare.
«Diglielo Fabbià, diglielo che la pistola è tua. Diglielo che me l’hai data tu… edddai…»
I due iniziarono ad accusarsi reciprocamente sotto gli sguardi divertiti dei poliziotti.
«Iooo!?! – replicò Fabiano – Nooo, la pistola è tua!»
Il maresciallo fece nuovamente la comparsa nella stanza dove si trovava il gruppo dei tre, sembrava assai contrariato per l’accaduto e si lasciò andare a dure ammonizioni del tipo: «Disgraziati! Voi non sapete dove finisce la schiena e dove invece incomincia il culo».
Lambrotta, accomodatosi in maniera stravaccata sulla sedia dietro la scrivania, cominciò a verbalizzare utilizzando una vecchia macchina per scrivere Olivetti. Pigiava sui tasti velocemente, però ogni tanto si sbagliava.
«Marko Orsini, nato all’Asmara; residente in Via Isacco Neuton, Nevton.. ma cumm’cazz s’ascrive stu’ nomm?»
Redatto il verbale prese Marko per un braccio e lo condusse in un locale attiguo completamente privo di finestre. Gli altri tre lo videro passare nel corridoio e Ivan abbozzò a bassa voce un commento: «Adesso lo gonfia di botte».
Non andò così, perché nei fatti il poliziotto si comportò con molta umanità.
«Io ti debbo arrestare – gli disse fissandolo negli occhi -, purtroppo non posso fare altrimenti. Se non avessi avuto la pistola ti avrei potuto rimandare a casa denunciandoti a piede libero, ma con tutto il casino che hai combinato in giro non posso fare più niente».
Lambrotta aveva compreso che quello che aveva davanti non era altro che un adolescente fragile che cercava di camuffare la sua insicurezza mascherandosi da duro. Egli sapeva perfettamente anche che di lì a poco quel ragazzino fragile si sarebbe dovuto confrontare con un ambiente totalmente diverso dal suo, quello del riformatorio.
«Tu sei minorenne e incensurato – gli disse cercando di incoraggiarlo -, vedrai che al massimo in tre o quattro giorni esci».
I due uscirono fuori dalla stanzetta buia. Marko si rivolse a Reiner non riuscendo a trattenere le lacrime e, abbracciandolo in segno di saluto, gli domandò quasi incredulo: «Ma, allora mi arrestano per davvero…». Poi ciese a Ivan di prestargli la sua giacca a vento blu, poiché voleva evitare di entrare in carcere con la mimetica, non voleva dare nell’occhio per non andare incontro ad altre grane.
A questo punto gli agenti lo portarono via, mentre gli altri tre dopo gli accertamenti di rito sarebbero stati rilasciati. Adesso restava soltanto da fare la traduzione a Casal del Marmo.
La Giulia Super risalì la rampa del commissariato. Appena fuori da Via Chianti Lambrotta accese la sirena monotonale e il lampeggiante blu. Pioveva ancora e le goccioline d’acqua imperlarono il parabrezza della volante. Serpico allora azionò i tergicristalli.
Sotto gli occhi di Marko passarono le ultime immagini del mondo esterno prima della detenzione.
Piazza Bologna adesso si era popolata di gente, chi andava a comprare il giornale in edicola, chi in pasticceria. Alcune automobili parcheggiate in doppia fila intralciavano il traffico, insomma, era il solito lento e pigro traffico domenicale di un quartiere borghese romano.
La volante superò tutti contromano. Superata Piazza Fiume imboccò il sottopassaggio fino a Villa Borghese. A Piazzale Flaminio un altro rallentamento, stavolta provocato dai primi tifosi che stavano andando ad assistere alla partita di calcio.
«Eccoli qua gli altri stronzi… guarda questi, questi mica ci arrivano allo stadio sai…», bisbigliò Serpico mentre venne costretto a ingranare la marcia più bassa per sorpassare un furgone che procedeva lento in mezzo alla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Da un autobus della linea 67 alcuni tifosi romanisti sportisi dai finestrini aperti scandivano slogan minacciosi, alcuni di loro agitavano ritmicamente e in modo coordinato le loro braccia tese con le tre dita della mano unite nel segno della P-38, la pistola prediletta dagli extraparlamentari nei violenti sconti di piazza che in quegli anni vedeva protagonisti autonomi e celerini.
Fuori dall’autobus esponevano uno striscione con i colori della loro squadra, Fedayn Quadraro c’era scritto sopra. Marko dall’abitacolo della macchina della Polizia riuscì a vederlo soltanto con la coda dell’occhio.
Più avanti, la Giulia fu costretta a fermarsi a causa di un piccolo ingorgo stradale formatosi davanti a Palazzo delle Ancore. Una ragazza, dal marciapiede sbirciò dentro la volante incrociando il suo sguardo con quello di Marko. È carina, pensò per un attimo lui.
Ripartirono quasi immediatamente e in poco tempo raggiunsero Via Trionfale, un arteria periferica nella quale il traffico si andava via via rarefacendo.
«Ci siamo, ecco il carcere minorile», disse Serpico mentre la porta carraia lentamente si apriva. La volante entrò nel complesso e tutto si compì.
Stadio Olimpico, Curva Sud. Ore quattordici. Ivan, Reiner e Fabiano avevano deciso di andare comunque alla partita, ma una volta arrivati sugli spalti si erano resi conto che quel giorno era accaduto qualcosa di strano. Erano in corso incidenti tra tifosi e Forze dell’ordine in entrambi gli opposti settori dello stadio.
La Curva Nord, occupata dai Laziali, era completamente avvolta in una densa nube di lacrimogeni. Uno spettatore che si trovava seduto accanto alla moglie, Vincenzo Paparelli, poco prima era stato colpito a morte da un razzo lanciato dalla Curva Sud da alcuni ultrà romanisti.
Un razzo da segnalazione nautica, uno di quelli che usano i diportisti per richiamare l’attenzione dei soccorritori quando in navigazione sono costretti a lanciare un SOS. Una volta acceso raggiunge la quota, poi per mezzo di un piccolo paracadute ridiscende lentamente illuminando il cielo sovrastante l’imbarcazione in difficoltà con un intenso bagliore rosso.
Alcuni ragazzi appartenenti alle frange più dure del Commando Ultrà avevano modificato quei razzi asportandone il paracadute e quindi li avevano lanciati contro i tifosi avversari avvalendosi di un tubo metallico. Si erano costruiti un rudimentale ma micidiale bazooka.
Quella mattina di quei razzi ne erano riusciti a lanciare tre. Il secondo di essi, dopo aver sorvolato il terreno di gioco aveva colpito al volto il tifoso laziale, che dopo alcuni istanti era morto.
In Curva Nord era subito esplosa la guerriglia, erano rimaste solo alcune migliaia di persone, poiché il grosso degli spettatori aveva preferito abbandonare lo stadio. Ultras Lazio ed Eagles Supporters avevano ingaggiato violenti scontri con i Carabinieri in servizio di ordine pubblico in quel settore.
Dalla parte opposta anche i romanisti avevano iniziato ad attaccare i celerini schierati a bordo campo e anche lì erano si erano verificati disordini.
Fabiano si unì al gruppo più esagitato dei facinorosi, e dal parterre aveva iniziato a lanciare corpi contundenti contro i poliziotti.
Ivan e Reiner, al contrario, si sederono nei posti in cima alla curva, dove ritrovarono il resto degli amici.
«Perché avete fatto così tardi? Che vi è successo? Vi abbiamo aspettati vicino a Piazza Istria…», domandò a Ivan uno delle Sag.
«Le guardie se so’ bevuti Attila» rispose lui.
A quel punto, come se fosse stato colto da un raptus, in uno stato di totale agitazione psicomotoria, l’altro iniziò a gridare paonazzo in volto come un ossesso incitando contestualmente a gesti la folla circostante:
«Hanno arrestato Attila! Hanno arrestato Attila!!!».
Quindi, col carisma proprio di un capopopolo scandì lo slogan ritmandolo:
«At-ti-la lib-be-rò! At-ti-la lib-be-ro!».
Naturalmente, dopo acni minuti nessuno di loro pensò più a quel teppistello di buona famiglia che, disperato, se ne stava rinchiuso nel carcere minorile, neppure l’esagitato capopopolo delle Sag.
In fondo c’era altro a cui pensare adesso, le autorità di pubblica sicurezza avevano stabilito che malgrado la morte del tifoso per ragioni di ordine pubblico la partita di calcio si sarebbe dovuta disputare lo stesso.
Sarebbe finita in parità, uno a uno: al quinto minuto del primo tempo, con una rete segnata di testa dal mediano biancazzurro Zucchini su assist di Garlaschelli la Lazio sarebbe passata in vantaggio, quindi, soltanto dieci minuti dopo, la Roma avrebbe pareggiato con un goal del centravanti Roberto Pruzzo su cross di Amenta.